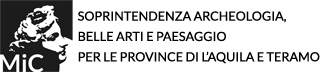Ricerche archeologiche nel territorio di Barisciano.
L’abitato dei Vestini, il vicus romano, l’insediamento medievale.

Il Furfo Project è un progetto di ricerca interdisciplinare organizzato, a partire dal 2023 per una durata triennale, dall’Università dell’Aquila – Dipartimento di Scienze Umane (DSU), in convenzione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo, la British School at Rome e il Comune di Barisciano.
Il Progetto ha per oggetto di lavoro il vicus di Furfo, un importante sito archeologico ricadente nel Comune di Barisciano (L’Aquila, Abruzzo), posto lungo il tracciato della via Claudia Nova.
Il sito occupato da questo importante vicus è oggi completamente preservato, libero da presenze moderne in quanto utilizzato per soli scopi agricoli. La sua identificazione, già da tempo acquisita, è stata dovuta alla presenza di numerose epigrafi che lo menzionano, recuperate dal campanile (oggi distrutto) della Chiesa di Santa Maria di Farfona (o Forfona), chiesa che conserva peraltro, nella sua denominazione, un’ulteriore attestazione del toponimo antico.
Si tratta di un particolare tipo di abitato, non una città dotata di amministrazione propria ma centro di riferimento di entità territoriali di carattere più aperto, tipologia ben nota, in particolare nelle regioni appenniniche dell’Italia centrale (S. Sisani, “In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra la Media Repubblica e l’età municipale”, in Memorie della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, Accademia Nazionale dei Lincei, 27.2, 2011, pp. 544 – 780.). Di questo tipo di forma insediativa tuttavia pochissimi sono gli esempi noti per via archeologica, nessuno dei quali indagato con sistematicità.
Il vicus di Furfo inoltre ha caratteristiche giuridiche che lo rendono un unicum nel panorama dei siti di simile tipologia: esso sembra aver avuto magistrati propri (gli aediles della Lex Aedis Furfensis), in contrasto a quanto sappiamo di tutti gli altri vici dell’Italia antica.
La lunga continuità di vita (dall’età vestina al XIII sec. almeno), lo stato di conservazione, le problematiche storico-archeologiche e le condizioni di operatività ne fanno dunque oggetto privilegiato per una ricerca archeologica interdisciplinare.
L’area di Furfo, ben perimetrabile già dall’analisi delle foto aeree, è solo in parte archeologicamente nota grazie a ricognizioni condotte negli anni ’80 del novecento (E. Gizzi, M. Spanu, M. Valenti, “Risultati preliminari della ricognizione archeologica nell’area dell’antica Furfo”, in A. Campanelli (a cura di), Peltuinum, antica città sul tratturo, Pescara 1996, pp. 26-31), che hanno consentito di precisare alcune delle aree presumibilmente occupate dal vicus e di supporre la presenza di un circuito difensivo.
Subito fuori dall’area del vicus, a nord ovest di questo, è conservato l’unico resto monumentale oggi visibile. Si tratta di una piccola fontana, oggi per la gran parte interrata, con pareti e volta costruite in opera quadrata di tufo. Nella parete destra della fontana è conservata, incisa su un unico blocco, l’iscrizione (CIL IX, 3521), databile fra i decenni centrali del I sec. a.C. e la fine dello stesso, che ricorda la dedica della struttura da parte di quattro mag(istri) pagi de v(ici) s(ententia).
Le emergenze monumentali dell’area si completano con i resti ancora visibili di un’aula, preziosa per architettura e resti della decorazione pittorica, che doveva far parte della medievale chiesa di Santa Maria di Forfona, costruita forse intorno al XII sec. presso il margine occidentale del vicus; l’intera struttura, ridotta ai soli muri perimetrali, giace invasa dalla vegetazione e interrata, ed è ancora tutta da documentare e comprendere nella sua articolazione storica e architettonica.
Da una zona prossima allo stesso vicus, genericamente indicata come …inter Sinizzum et Furfonem.., proviene infine l’importantissima iscrizione nota come Lex Aedis Furfensis (CIL IX, 3513), databile al 58 a.C. grazie alla menzione della coppia consolare. Il testo, ricordando la dedica di un tempio Iovis Liberi Furfone, riporta testimonianze sul ruolo stabilito dalla Lex Sacra per il vicus di Furfo, con i suoi aediles, nel governo delle cose del tempio, in partecipazione con altre entità vicane non altrimenti note ma probabilmente circostanti (U. Laffi, “La lex Aedis Furfensis”, in La cultura italica, Atti del Convegno della Società italiana di glottologia (Pisa 19 e 20 dicembre 1977), Pisa 1978, pp. 121-144). L’identificazione del luogo di provenienza dell’iscrizione, e dunque la localizzazione del tempio, sarebbe un risultato di altissimo livello, anch’esso obiettivo del progetto.
Ancora mai indagato l’insediamento vestino, che moltissimo materiale ceramico sparso sulla superficie del pianoro indica essere stato assai consistente per estensione. Altrettanto, totalmente sconosciuto quello medievale, che doveva svolgersi attorno alla chiesa.

In tali condizioni, il progetto di ricerca si propone di avviare un’indagine sistematica e multidisciplinare sul sito dell’importante vicus, permettendo a un team internazionale di operare in stretto contatto e in continua condivisione di temi e metodologie.
L’obiettivo finale è quello di una conoscenza quanto più completa possibile del sito, raggiunta tramite mappatura iniziale, successive campagne di scavo, progressiva edizione dei risultati, tanto anno per anno quanto con una pubblicazione finale di sintesi.

Parallelamente al lato scientifico, la valorizzazione dei risultati è impegno condiviso dei partecipanti, perseguita tramite la periodica divulgazione dei risultati della ricerca e, a livello permanente, con l’auspicabile creazione di punti informativi e di percorsi di visita sul territorio.