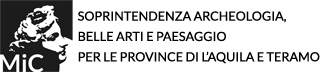Castel Del Monte – L’Aquila 25 Novembre 2023

Cenni storici e contestualizzazione dell’edificio:
Piccola chiesa situata accanto a una delle antiche porte d’accesso al borgo di Castel del Monte, San
Rocco presenta una semplice facciata con qualche sobrio elemento ornamentale a rilievo che decora il
portale e le finestre, ed è sormontata da un campaniletto a vela sul fianco sinistro.
La chiesa di San Rocco fu eretta dai superstiti della grande pestilenza del 1656, in onore del santo che
secondo la tradizione popolare si invoca come protettore dall’epidemia. Infatti, il 14 luglio di ogni anno,
giorno della festività di San Rocco, secondo l’antico statuto di Castel del Monte i membri della
Congregazione dell’Annunziata eleggevano il Priore e gli “Officiali”, in omaggio “di detto santo per
l’antica protezione implorata contro la peste”. Fuori dalla chiesa, a testimonianza della predilezione ad
essa accordata dalla cittadinanza, c’era una grande pietra, oggi distrutta, venerata dai Castellani e
utilizzata comesacro garante per i prestiti in denaro.
La semplicità delle fattezze esterne dell’edificio, non si rispecchia tuttavia nell’ambiente interno, dove
l’aula unica è arricchita nella parete di fondo da uno sfarzoso altare in legno intagliato e dorato adornato
da un dipinto collocato nella cimasa, da tre statue a tutto tondo e da numerose decorazioni fitomorfe e
antropomorfe di chiaro gusto barocco [FIG. 1].
Aspetti strutturali e decorativi dell’altare maggiore:
L’altare maggiore è scandito da quattro grandi colonne, realizzate in due stili differenti: quelle centrali
tortili, quelle laterali hanno il fusto scanalato, anche se tutte culminano con capitelli corinzi [FIG. 2].
Sopra la trabeazione si trova una cimasa terminante in un frontone: al centro di essa è collocato il dipinto,
eseguito ad olio su tela, nel quale si riconoscono la Madonna che cinge con una corona floreale Santa
Caterina da Siena (riconoscibile per l’abito da suora domenicana), la quale tiene nella mano destra un
fiore di giglio, mentre Gesù Bambino, stante sulle ginocchia della madre, porge a San Domenico (il
fondatore dell’ordine, motivo per cui indossa il tipico saio domenicano) un grande giglio, stringendo
nella mano opposta un crocifisso [FIG. 3].
Ai lati estremi dell’attico sono collocati due angeli, certamente reggenti in origine vessilli oppure cartigli
o altri elementi dispersi: quello di sinistra risulta però ora privo di entrambe le mani; l’altro, a destra, è
ancora riconoscibile come nell’atto di impugnare dei rotoli (da cui verosimilmente si snodava un cartiglio
recante un’iscrizione). Anche in cima al timpano triangolare sono collocati due angeli, raffigurati distesi
a gambe incrociate in posizione perfettamente speculare ai lati di una grande croce fiammeggiante (sono
ancora visibili le fiammelle raffigurate sul lato destro del braccio longitudinale).
Il registro inferiore, infine, si presenta ulteriormente arricchito dalla presenza di tre statue a tutto tondo,
intagliate e policromate, inserite in rispettive nicchie: le sculture sono rappresentanti il titolare della
chiesa, San Rocco, a sinistra San Michele Arcangelo e a destra San Giuseppe. Corre l’obbligo però di
segnalare come le tre sculture attualmente in situ non siano quelle originariamente ubicate nelle nicchie,
che furono trafugate nel 1981 e mai più recuperate [FIG. 4].
Attualmente, nella nicchia centrale è stata collocata una statua, sempre raffigurante San Rocco, risalente
agli inizi del XIX secolo e proveniente da un’altra chiesa castellana, quella di Santa Caterina; ai lati,
invece, ci sono due versioni moderne, di fattura didascalica, delle statue trafugate, raffiguranti
rispettivamente San Michele Arcangelo nell’atto di schiacciare il demonio e San Giuseppe riconoscibile
grazie agli attributi tipici del suo lavoro artigianale, ossia gli attrezzi da falegname tra cui la pialla.
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di L’Aquila e Teramo
Peculiarità iconografiche e materiche dell’altare:
Da un punto di vista iconografico, l’altare di Castel del Monte è certamente da interpretare come una
“macchina devozionale” tipicamente improntata ai dettami della Controriforma cattolica. La Chiesa
triumphans post-conciliare imponeva infatti che la funzione civile degli edifici ecclesiastici passasse
necessariamente in secondo piano, a favore della riattualizzazione di forme e strutture originali delle
basiliche paleocristiane per la voluta continuità tra la Chiesa delle origini e la Chiesa apostolica romana
rilanciata dal concilio tridentino, riportando così in auge elementi che diventarono ben presto caratteristici
del barocco aquilano: grandiose soffittature lignee e imponenti armadi di sacrestia, rifacimenti degli arredi
nella zona del transetto e del presbiterio che prevedevano, frequentemente, la realizzazione di cori lignei,
cibori, tabernacoli e nuovi sfarzosi altari, anch’essi non di rado realizzati in legno.
Si tratta di tutti elementi che si ritrovano ancora in situ, oppure -ancorché scomparsi o sostituiti da
analoghi elementi realizzati in epoca successiva – sono attestati dalle fonti documentarie come presenti,
già nell’ultimo scorcio del Cinquecento, nelle due prestigiose basiliche aquilane, Santa Maria di
Collemaggio e San Bernardino1, ma anche a Santa Giusta e a San Giuliano, e pure in chiese oggi
scomparse come Santa Croce, da cui proviene il magnifico altare ligneo tardo-cinquecentesco
successivamente trasferito nella tribuna della chiesa delle Anime Sante2.
Elementi che pertanto divennero caratteristici dell’altaristica barocca aquilana e di cui si può constatare
un larghissimo ricorso, per tutto il Seicento e buona parte del Settecento, in vari territori limitrofi al
capoluogo di regione, in particolare in quelle zone laddove era più agevole il rifornimento della materia
prima, ossia legni stagionati di ottima qualità, in particolare essenze di noce, pioppo, quercia e castagno
(queste ultime, in particolare, tradizionalmente impiegate anche nell’edilizia, ad esempio per la
realizzazione di coperture, solai, portoni, per la posa in opera di travature, ecc.3).
Questo spiega ad esempio la diffusione notevolissima che gli altari lignei conobbero nelle aree interne
dell’Abruzzo e per di più nelle zone montane, specialmente nelle cosiddette Terre della Baronia, nei
borghi dislocati sul versante teramano del Gran Sasso4
e ancora nel circondario -oggi in provincia di
Rieti- che partendo da Cittaducale arriva sino ad Amatrice- il quale storicamente ha fatto parte integrante
delle province degli Abruzzi da cui si è separato, dal punto di vista amministrativo, soltanto nel 1975.

BIBLIOGRAFIA
1 Cfr. A. Petraccia, Flaminio Boulanger “gallo de Urbe” a L’Aquila nel 1584. Una prima ricognizione sull’arte del legno per la
modernizzazione di L’Aquila a fine Cinquecento, in “Studi Medievali e Moderni” 15, 2011, n.s. Abruzzo. Un laboratorio di ricerca per la
scultura lignea, a cura di G. Curzi, A. Tomei, pp. 85-100; G. Simone, Gli altari di S. Maria di Collemaggio e di S. Bernardino a L’Aquila
sul finire del XVI sec.: Flaminio Boulanger e Orazio Valla, in G.G. Alferi, L’Istoria sacra delle cose piunotabili della citta dell’Aquila, a
cura di G. Simone, L’Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, 2012, pp. 323-363; F. Marcelli, La Controriforma
in Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila: un contratto e un inventario inediti per Giacomo della Porta e Flaminio Boulanger, in “Rivista
d’arte”, V serie, a. 50, n. 5, 2015, n.s. Sulla scultura lignea, pp. 97-134.
2 Cfr. G. Simone, La chiesa di Santa Maria del Suffragio in L’Aquila: note d’architettura e d’arte, in Santa Maria del Suffragio. La
rinascita, Stampato a cura della Regione Abruzzo, L’Aquila 2018, pp. 30-37.
3 Cfr. L. Serafini, L’uso del legno nella tradizione lignea costruttiva abruzzese: solai e coperture, in La costruzione tradizionale in
Abruzzo:fonti materiali e tecniche costruttive dalla fine del medioevo all’Ottocento, a cura di C. Varagnoli, Roma, 2008, pp. 65-82.
4 Sull’argomento si rimanda allo studio pionieristico, certamente ancora oggi di notevole utilità vista la mole eccezionale di altari lignei
documentati anche fotograficamente, firmato da M.A. Pavone, L’altare barocco, in Documenti dell’Abruzzo Teramano, sotto la direzione di
L. Franchi Dell’Orto, comitato di edizione: F. Bologna, M. Del Treppo, A. Giuliano, vol. I, tomo 1, La Valle Siciliana o del Mavone, Roma
1983, pp. 415-453.
5 Si veda per questa zona un primo censimento scientifico pubblicato ad opera di G. Simone, Altari lignei nell’Abruzzo Ulteriore II. Il
circondario di Cittaducale, in Abruzzo. Il barocco negato. Aspetti dell’arte del Seicento e Settecento, a cura di R. Torlontano, “Atlante
tematico del Barocco in Italia”, collana diretta da M. Fagiolo, Roma, De Luca Editori d’arte, 2010, pp. 150-165.